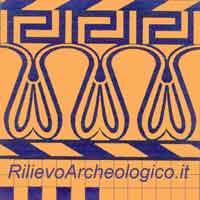|
INTRODUZIONE
Ho scoperto l’Abruzzo poco più di venti anni fa, quando conobbi Silvia Mari, mia moglie, che è originaria di Sante Marie. Facemmo le nostre prime gite che ancora non eravamo sposati. La prima volta andammo al castello di Tremonti, dove rimasi fortemente impressionato per la bellezza del luogo e soprattutto per il panorama sulle montagne intorno, coperte di boschi, punteggiate da minuscoli paesi, dietro le quali si stagliava la mole del Velino innevato, che passava dal colore dell’oro, al rosa, al viola cupo, mentre il sole tramontava. Da allora ho trascorso gran parte delle mie vacanze nella villa della famiglia di Silvia, non distante dalla stazione di Sante Marie, circondata da mezzo ettaro di pineta. Muovendomi da lì, ho girato la regione in lungo e in largo, ho visitato i suoi innumerevoli paesi e soprattutto sono salito sulle sue imponenti montagne. Sono andato su tutte le cime; nel massiccio del Velino posso dire di aver battuto ogni sentiero. Ho traversato boschi e vallate solitarie d’inverno con gli sci ai piedi. Ho fatto centinaia di chilometri in bici lungo interminabili salite e troppo rapide discese. Per la varietà dei suoi paesaggi, l’Abruzzo non mi ha mai stancato.
Da studioso di architettura antica nel corso delle mie numerose escursioni mi sono interessato anche di edifici e di strutture murarie — e oggi porto i risultati delle mie osservazioni in questo libro — ma debbo dire onestamente che l’attrazione che mi hanno suscitato in questi anni i centri storici della regione, non sarebbe stata la stessa senza il magnifico scenario naturale che li circonda.
Sono archeologo, ma in Abruzzo mi ha interessato e coinvolto molto di più ciò che sta al di là del 476 d.C., non solo chiese e fortezze medievali, ma anche il tessuto edilizio dei centri storici che risale in gran parte al settecento e all’ottocento. Il territorio di cui mi sono occupato, che corrisponde alla parte occidentale della Marsica, possiede numerosi importanti e sorprendenti monumenti archeologici, come le mura poligonali di villaggi e santuari italici e italico-romani o i grandi tumuli funerari dell’età del ferro dei Piani Palentini e della conca di Corvaro, che hanno trovato in questo libro il dovuto risalto insieme alle altre emergenze antiche. Ma sono in ogni modo i contesti postantichi, medievali e di età moderna, a cui ho voluto dedicare lo spazio maggiore. Ritengo che per uno studioso di architettura antica non ci debbano essere confini cronologici, perché le tecniche costruttive non conoscono modificazioni sostanziali dall’epoca romana fino all’evo moderno. Nei paesi di montagna questi metodi si sono protratti addirittura fino agli anni cinquanta del novecento. Persino i sistemi di produzione rimangono invariati. Uno dei casi più interessanti, a cui ho dedicato un intero capitolo, è quello delle fornaci di laterizi di Poggetello, nel comune di Tagliacozzo, dove fino a sessant’anni fa si fabbricavano i mattoni utilizzando le stesse procedure delle fornaci romane di epoca imperiale e di quelle dell’Oriente antico.
L’osservazione e l’analisi di edifici che sono relativamente integri, perché più recenti, è di grande aiuto per ricostruire la morfologia di quelli antichi, dove restano solitamente poche tracce dei vari elementi architettonici, non facilmente interpretabili. In quest’ottica si è rivelato assai utile ascoltare le voci degli anziani operai e artigiani del posto che raccontano in maniera molto dettagliata il lavoro che svolgevano da ragazzi nei cantieri o negli impianti di produzione dei materiali (fornaci per laterizi, calcare, botteghe artigiane, eccetera). Tutti loro applicavano gli stessi procedimenti già adottati dagli antichi, perché questi rispondono al modo più logico ed efficiente di operare, disponendo di determinati materiali da costruzione — che sono quelli reperibili localmente — e avvalendosi di pochi essenziali strumenti, anche questi rimasti sostanzialmente invariati attraverso i secoli.
D’altra parte la metodologia di indagine che è comunemente adottata dagli archeologi per interpretare e ricostruire i manufatti dell’antichità, la quale si basa sul rilievo e l’analisi dei resti visibili, sul confronto con analoghi contesti che sono meglio comprensibili, sulla raccolta delle fonti docu-mentarie, orali e iconografiche in grado di descrivere le condizioni originarie dell’oggetto in esame, costituisce il mezzo più efficace anche per studiare gli edifici di epoche più recenti, non solo quelli medievali — il filone di studi dell’archeologia medievale si è imposto sulla scena ormai da decenni — ma persino quelli di età moderna. Tra questi ultimi sono ormai numerosi quelli allo stato di rudere; si pensi ad esempio ai tanti fabbricati rurali abbandonati in mezzo alle campagne, i quali sono inesorabilmente condannati a un rapido disfa-cimento una volta crollate le coperture. Si deve considerare inoltre che gli edifici storici che sono ancora integri perché abitati hanno conosciuto nel corso del tempo, soprattutto negli ultimi decenni e in modo particolare negli interni, delle radicali trasformazioni. Quindi anche l’edificio “integro” in realtà va “ricostruito”, utilizzando gli strumenti di indagine che sono abituali all’archeologo, cercando di distinguere la sequenza delle modificazioni intervenute (fasi) e di arrivare a figurarsi la sua morfologia originaria.
Confesso che varcare la soglia del 476 d.C. mi ha dato anche una sensazione di grande libertà. In Italia il patrimonio archeologico è di fatto in gran parte blindato e invedibile. Da una parte ci sono comprensibili esigenze di tutela: la maggior parte degli scavi archeologici vanno rinterrati per non esporli alle intemperie e solo chi ha concretamente partecipato ai lavori sarà in grado di descrivere e interpretare ciò che era stato messo in luce; il resto del mondo per saperne qualcosa dovrà attendere la doverosa pubblicazione. Molte delle cose che però potrebbero essere rese visibili, diciamolo francamente, vengono tenute rigorosamente chiuse a chiave dalle Soprintendenze, o dagli altri enti competenti, e con sempre più difficoltà viene consentito l’accesso a quegli studiosi esterni che ne fanno richiesta, non parliamo poi dei “comuni mortali”. Gli enti responsabili si trincerano dietro la motivazione della mancanza del personale e delle carenti condizioni di sicurezza. La verità è che i beni archeologici vengono gelosamente tenuti nascosti per riservarsi la pubblicazione di qualche articolo sulle riviste scientifiche di settore, il quale verrà letto al massimo da quattro persone in tutta Italia, ma che è assolutamente necessario produrre in esclusiva per impinguire il proprio curriculum ai fini dei concorsi, degli avanzamenti di carriera o per vanità personale. Il paradosso è che spesso chi serra il monumento, non trova poi il tempo per studiarlo e molti progetti di pubblicazione restano nei cassetti per decenni.
La Marsica postantica per me è stato innanzitutto un viaggio verso la libertà, attuato come poteva farlo il Tomassetti alla fine dell’ottocento quando si dedicava allo studio dei monumenti archeologici della campagna romana, che erano ancora totalmente a disposizione del viandante. Ha significato partire quasi ogni mattina in bici dalla casa di Sante Marie e poter andare in qualunque luogo, sui castelli in cima alle montagne o nei casaletti in mezzo ai boschi, fotografando, misurando, senza limitazioni e senza dover rendere conto a nessuno, con i problemi di sicurezza che si ponevano all’interno di edifici pericolanti risolti semplicemente con il buon senso e l’esperienza di chi fa rilievi da trent’anni. Non parliamo poi degli edifici storici che sono abitati. Qui ho trovato quasi ovunque porte spalancate — esperienza davvero insolita per un archeologo! — massima disponibilità, cortesia, voglia di raccontare. D’altra parte i proprietari delle case erano molto gratificati nel vedere che io e Silvia lanciavamo entusiastici apprezzamenti per delle loro cose — mobili o parti dell’abitazione - che fino al giorno prima avevano considerato povere e prive di interesse. Silvia mi ha spesso accompagnato, filmando e registrando i nostri numerosi ospiti. Nel frattempo ha montato due filmati sulle interviste che abbiamo fatto ai fornaciai di Poggetello, che abbiamo poi proiettato alla Proloco del paese, e qualche giorno dopo in una sala comunale a Sante Marie, con molto pubblico e molta partecipazione.
Vorrei fare anche qualche considerazione sul rilievo dei monumenti, disciplina che insegno all’università e sulla quale ho scritto un manuale che tratta sia del rilievo diretto sia delle tecnologie informatiche più evolute. Viviamo in un periodo in cui gli enti pubblici hanno sempre meno soldi per i beni culturali, ma d’altra parte qualunque intervento si voglia portare avanti deve costare somme astronomiche. In questi ultimi anni assistiamo alla esaltazione positivista dei laserscanner, dei GPS cinematici, dei Personal Data Assistant da campo in collegamento wireless, dove una qualunque legittima preoccupazione in merito all’effettiva bontà del risultato finale del lavoro viene spazzata via da un atteggiamento di illimitata fiducia per il miracolistico (e costosissimo) strumento di precisione. Con mezzi assai più modesti e lavorando da solo, in questi ultimi mesi tra le montagne marsicane ho eseguito una dozzina di rilievi diretti, che presento in questo libro. Mi è bastato portarmi appresso, sulla bici, una borsa a tracolla contenente pochi ed essenziali attrezzi: un distanziometro laser tascabile comperato da un ferramenta di Avezzano, un flessometro di metallo di 7,5 m, una macchinetta fotografica digitale, qualche foglio di carta, matita e gomma per appuntarmi le misure. In ogni posto dove sono andato me la sono cavata con non più di mezza giornata di lavoro. Non posso certamente garantire che tutte le mie misurazioni risultino della massima precisione; ma siccome nel rilievo in primo luogo bisogna metterci la testa, ritengo che le mie planimetrie e sezioni molto artigianali possano aiutare a interpretare gli edifici che vi sono rappresentati forse un po’ meglio rispetto a una nuvola di milioni di punti restituita dal laser scanner, all’interno della quale non si riesce a distinguere con chiarezza un solo elemento architettonico.
L’ambito territoriale che ho preso in considerazione è quello della Marsica occidentale, ossia tutta l’area situata tra i Piani Palentini e la Piana del Cavaliere, comprendente i comuni di Scurcola, Tagliacozzo, Sante Marie, Carsoli, Pereto, Oricola, Rocca di Botte, parte di quelli di Magliano, di Pescorocchiano e di Borgorose; questi ultimi due, ora situati nel Lazio, fino al 1927 fecero parte della provincia di L’Aquila. È un’area che ha una sua omogeneità geografica, storica e culturale, la quale corrisponde in gran parte al territorio della contea di Tagliacozzo e Albe del tardo medioevo, divenuto poi ducato sotto i Colonna dalla fine del quattrocento al 1806. Corrisponde anche alla parte maggiore del territorio abitato anticamente dagli Equi, mentre i Marsi erano stanziati nel bacino del Fucino e nelle vallate circostanti. L’estensione del nome Marsica a tutta la regione posta a occidente di Alba Fucens, fino ai confini del Lazio, è avvenuta nell’alto medioevo. Ma questa ha mantenuto anche successivamente una separazione politica dalla Marsica vera e propria sviluppando una propria identità. Il terremoto del 1915 ha segnato una ulteriore linea di demarcazione tra le due aree. I centri storici a est di Scurcola sono stati rasi al suolo e non sono più stati ricostruiti; quelli della Marsica occidentale invece si sono salvati.
Il vasto territorio comunale di Sante Marie, con le sue numerose frazioni, costituisce l’epicentro di quest’area e ne assomma gli aspetti più caratteristici. È stato il contesto preso maggiormente in considerazione, soprattutto per quanto riguarda l’edilizia di età moderna, rubando un po’ la scena, una volta tanto, alla onnipresente Tagliacozzo; anche questa città in ogni caso ha trovato nel libro la sua meritata considerazione data l’importanza della sua storia e del suo patrimonio artistico; allo stesso modo trovano ampio spazio quasi tutte le altre località dell’area in oggetto comprese numerose piccole frazioni. Il libro non è però una pedissequa schedatura di tutto quello che c’è sul territorio; è invece una illustrazione degli episodi più significativi, quindi ci saranno inevitabilmente anche molte assenze. Tra l’autunno 2010 e la primavera 2011 ho girato con Silvia, che è architetto, per le varie località della Marsica occidentale dove abbiamo scattato centinaia di fotografie, profittando anche del fatto che in inverno la vegetazione è spoglia e nelle campagne c’è più visibilità. Abbiamo contattato anziani artigiani e operai, in particolare la piccola colonia dei vecchi fornaciai di Poggetello, ai quali abbiamo fatto numerose interviste filmandoli e registrandoli. Metteremo questo materiale in internet nel più breve tempo. Mi sono fermato stabilmente sul posto per tutto luglio e agosto 2011 e mentre terminavo di scrivere il libro mi sono mosso ogni giorno, quasi sempre da solo, arrampicandomi con la bici sulle numerose salite, per fare rilievi, fotografie e riguardare molte cose con la dovuta attenzione. Silvia nel frattempo ha lavorato sui filmati, mi ha sempre molto sostenuto e le sono grato per questo. Ho effettuato l’ultimo rilievo al castello di Tremonti, in una luminosa e ventilata mattinata di fine agosto, con una vista molto limpida sul Velino che sembrava a portata di mano come nei giorni invernali; è stata una gita piacevolissima che mi ha riportato all’atmosfera della prima volta.
Questo libro è senz’altro un atto di amore verso questa terra e vuole essere un piccolo contributo a favore della tutela e della valorizzazione del suo patrimonio storico-culturale. Ne ho parlato nell’ultimo paragrafo: negli anni settanta e ottanta del secolo scorso, quando finalmente è arrivato il benessere, sulle povere case di pietra dei paesi di montagna si è abbattuto un furore distruttivo, teso a cancellare ogni ricordo di una povertà troppo recente. Era legittimo e comprensibile voler finalmente abitare in una casa confortevole, dotandola di bagno, cucina a gas, impianto di riscaldamento efficiente, mobili comodi. In molti casi però purtroppo le stesse radicali trasformazioni hanno investito anche gli esterni, rischiando di compromettere fortemente l’immagine di questi bellissimi paesi. Negli ultimi anni c’è stato finalmente un grosso cambiamento di mentalità. Si è visto da parte della gente il bisogno di conoscere la propria storia e recuperare le proprie tradizioni in ogni campo con un forte senso di orgoglio e di appartenenza. E si comincia finalmente anche a restaurare le case in modo diverso. I paesi della zona nel complesso, rispetto a molte altre realtà dell’Italia meridionale, sono ancora molto gradevoli e sono tante le case che hanno conservato le loro fattezze originali. Alcuni borghi sono piccoli gioielli.
Penso che il mio lavoro possa inserirsi utilmente in questo nuovo clima che sta maturando perché diffondere la conoscenza dell’architettura storica può aiutare a eseguire restauri più rispettosi e attenti anche nei dettagli. Mi rendo conto che la casa in cui si abita non può essere trasformata in un museo, servono il bagno e molte altre cose. Ma qualcosa in più si può tentare di preservare. I pavimenti in laterizi quadrati di Poggetello, anche se crepati meritano di essere salvati, perché saranno comunque assai più gradevoli e meno banali delle piastrelle in finto marmo. Allo stesso modo un tramezzo realizzato con i materiali tradizionali, come il c.d. fratticcio, che a detta dei vecchi operai è molto più resistente di quelli che si costruiscono oggi, si può tentare di lasciarlo dove sta e chisseneimporta se la divisione planimetrica dell’interno non sarà così “razionale” come stabilito nel progetto del nostro geometra di fiducia. Una casa storica sarà in ogni modo più bella e avrà un valore di mercato maggiore rispetto a un’abitazione che non si distingue da quelle della periferia romana. Le mie “osservazioni” si rivolgono ovviamente anche alle pubbliche amministrazioni locali che potrebbero regolare i restauri dei privati con apposite normative, impedire il perpetuarsi di certi scempi sugli esterni, regolamentare i colori degli intonaci nei centri storici, incentivare anche fiscalmente gli interventi di ripristino delle facciate volti a eliminare le brutture dei restauri del passato. La Pubblica Amministrazione potrebbe fare molto quando acquisisce immobili di interesse storico-architettonico promuovendo restauri filologici anche negli interni, cosa che puntualmente non avviene, perché l’unica finalità diventa quella di ricavare spazi comodamente fruibili, adatti per esposizioni o altri usi collettivi, per cui i lavori di restauro — che vengono affidati a ditte che hanno interesse a lavorare in modo molto sbrigativo per ricavare il massimo profitto — si risolvono il più delle volte facendo tabula rasa di tutto quello che c’era all’interno e così il restauro per mano pubblica si trasforma nell’ennesima occasione perduta.
Indispensabile poi è la tutela del paesaggio. Il territorio in oggetto si è ancora in gran parte salvato dalla inarrestabile colata di cemento che sta invadendo le campagne italiane, cancellando ettari di terreno agricolo, per sostituirli con centri commerciali e migliaia di nuove case che non si capisce perché non bastano mai in un paese dove la crescita demografica si è fermata da quarant’anni. Sono politiche che non solo devastano il territorio, ma arricchiscono un ristretto numero di speculatori impoverendo la gran massa degli italiani che sono piccoli proprietari perché finiscono per abbattere il valore di mercato della casa, come è già successo con esiti drammatici in altri paesi. Alla periferia di Tagliacozzo si continua a costruire senza sosta complessi di insulse villette, nel frattempo il bellissimo centro storico, come tutte le frazioni di montagna, è pieno di cartelli “Vendesi”. I proprietari di queste case, a causa della concorrenza sleale dei “palazzinari”, sono costretti a svenderle per quattro soldi e in queste condizioni non hanno il respiro economico per avviare piccole attività imprenditoriali a conduzione famigliare, come i bed and breakfast e simili che potrebbero favorire il recupero dei vecchi borghi. Ci sono due modelli di sviluppo alternativi e anche in merito a questo rimando a quanto ho scritto nelle conclusioni: l’uno distrugge l’ambiente e arricchisce i soliti noti, l’altro può tutelare l’ambiente e favorire una più equa e democratica distribuzione delle risorse.
(1. Lineamenti storici ed economici; 2. L'immagine dei paesi tra ottocento e novecento). Testo integrale (PDF)
|
- Manuale di rilievo e di documentazione digitale in archeologia
- Le tecniche edilizie nel mondo antico. Presentazione.
- Ricostruzione 3d di un edificio arcaico in opus craticium
|